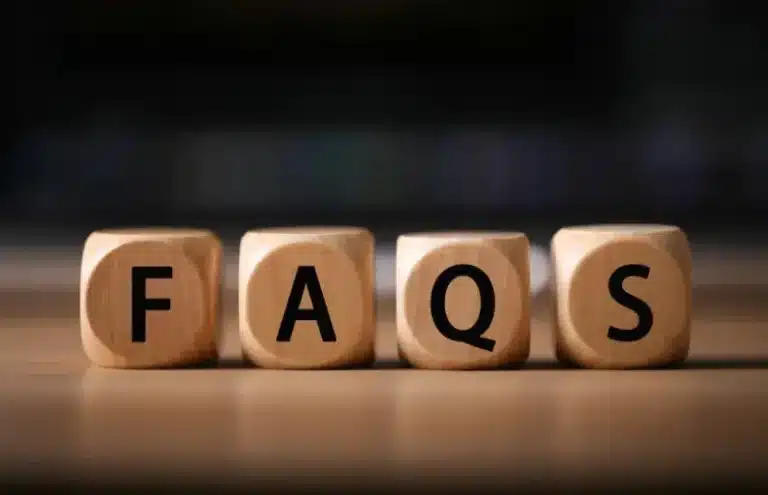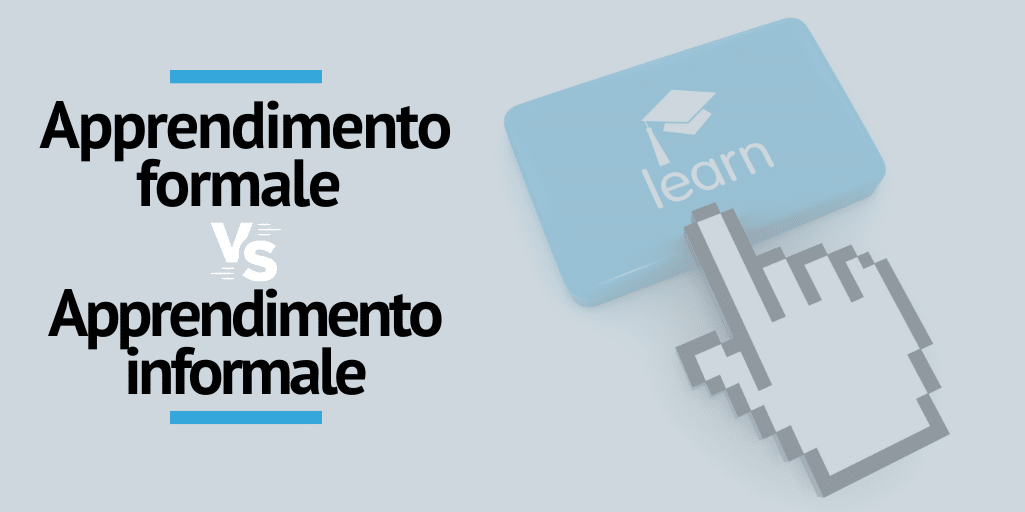Per decenni, l’apprendimento formale è stato associato quasi esclusivamente alle aule, ai diplomi e ai programmi strutturati. La conoscenza veniva trasmessa da una figura esperta al discente seguendo una sequenza definita e validata. In questo contesto, l’apprendimento formale si è consolidato come garanzia di competenza, e il progresso accademico o professionale passava attraverso quel percorso prestabilito.
Ma se quel modello non fosse più sufficiente?
Nel contesto attuale, segnato dalla velocità del cambiamento, dall’accesso costante all’informazione e dalla trasformazione digitale nell’istruzione, apprendere non è più un momento specifico, ma è diventato una pratica continua.
Ogni conversazione, ogni problema che risolviamo con un collega o ogni risorsa che cerchiamo online fa parte di ciò che oggi intendiamo come apprendimento informale.
Le organizzazioni più innovative stanno iniziando a valorizzare questo tipo di esperienze come parte essenziale delle loro strategie di formazione, riconoscendo che la trasformazione dell’apprendimento non passa più solo attraverso contenuti strutturati, ma richiede la creazione di ambienti che favoriscano l’interazione, l’autonomia e lo sviluppo pratico.
Ha ancora senso parlare di apprendimento formale e informale come due mondi separati? Qual è il ruolo dell’apprendimento non formale in questa equazione? E come dovrebbero aziende e centri formativi adattarsi a questo scenario in evoluzione senza perdere rigore ed efficacia?
La risposta non è binaria. Il futuro della formazione professionale richiede di combinare il meglio di entrambi gli approcci, comprendendone i limiti, i punti di forza e, soprattutto, i nuovi contesti di apprendimento formale, non formale e informale che emergono con forza nell’era della transizione digitale nell’education.
Apprendimento formale vs apprendimento informale: definizione, differenze e contesti
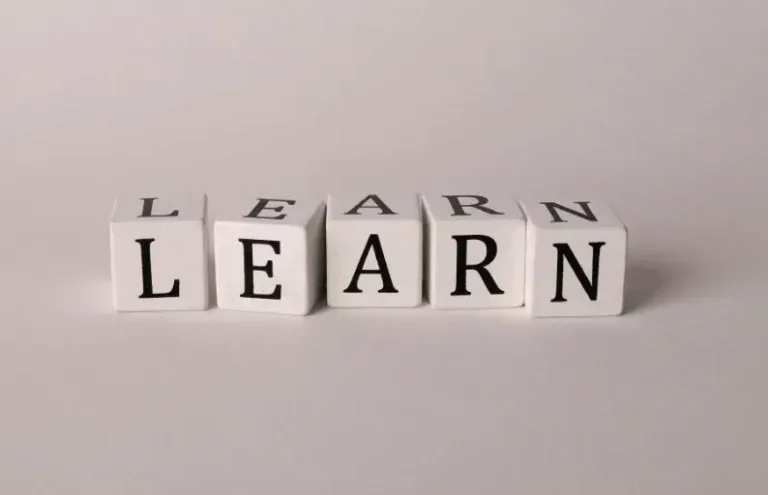
Si può imparare senza un’aula, senza un formatore, senza un esame finale?
Questa domanda, che qualche decennio fa sarebbe sembrata provocatoria, oggi è quasi inevitabile in qualsiasi conversazione sulla formazione professionale.
L’accesso massivo all’informazione, i nuovi strumenti digitali e i cambiamenti nel modo di lavorare hanno trasformato profondamente il nostro modo di acquisire conoscenze.
Per questo motivo, prima di analizzare dove sta andando la formazione, è fondamentale comprendere cosa significa apprendimento formale e informale, così come i contesti di apprendimento formale, informale e non formale in cui ciascuna modalità si sviluppa.
Cosa intendiamo per apprendimento formale
L’apprendimento formale è quello che avviene in contesti strutturati, pianificati e regolati da un’istituzione. Include dalla formazione scolastica a quella universitaria, passando per corsi regolamentati, percorsi certificati o programmi ufficiali finanziati.
La sua caratteristica distintiva è la presenza di un piano di studi definito, obiettivi pedagogici chiari e un sistema di valutazione che certifica l’acquisizione delle conoscenze.
In ambito professionale, questo tipo di apprendimento continua ad avere un ruolo rilevante, soprattutto quando sono richieste certificazioni ufficiali o basi teoriche solide. Le piattaforme di formazione eLearning permettono di replicare lo stesso rigore anche in ambienti digitali, offrendo corsi strutturati con monitoraggio e certificazione, senza rinunciare alla flessibilità richiesta dalle organizzazioni di oggi.
Cos’è l’apprendimento informale e come si manifesta nella pratica
A differenza del precedente, l’apprendimento informale non segue uno schema prestabilito né necessita di una struttura formale per avvenire. È spontaneo, spesso invisibile, ma estremamente prezioso.
Avviene nelle conversazioni con i colleghi, nella ricerca autonoma di informazioni, nella risoluzione di un nuovo problema o semplicemente osservando qualcuno che svolge un’attività. È, in sostanza, l’apprendimento che si verifica mentre lavoriamo, collaboriamo o esploriamo attivamente.
Questo tipo di apprendimento è strettamente legato alla trasformazione digitale nell’istruzione superiore e nell’ambiente aziendale, poiché gli strumenti digitali hanno moltiplicato le opportunità di accedere a conoscenze in tempo reale.
In un mondo in cui l’urgenza non sempre aspetta una formazione strutturata, la capacità di apprendere al volo diventa una competenza strategica.
Inoltre, questo approccio si collega a tendenze attuali come il microlearning, l’apprendimento in rete o l’uso delle ultime tendenze dell’IA generativa nella formazione, in cui l’informale diventa sempre più sofisticato ed efficace.
L’apprendimento non formale: una via intermedia
Tra questi due estremi si colloca l’apprendimento non formale, una categoria che spesso passa inosservata ma che è fondamentale nei contesti professionali.
Si tratta di percorsi formativi che, pur non essendo regolati da un sistema educativo ufficiale, sono intenzionali, strutturati e organizzati. Ne sono esempi i workshop aziendali, i corsi di formazione continua, i bootcamp, le sessioni di coaching o le comunità di pratica.
Anche se non sempre portano a una qualifica formale, queste esperienze hanno obiettivi chiari, strutture definite e, in molti casi, un alto grado di applicabilità diretta.
Rappresentano un elemento chiave per rispondere alle sfide della transizione digitale formazione, poiché permettono di adattarsi rapidamente a esigenze in evoluzione, mantenendo al contempo una certa coerenza metodologica.
Questo tipo di apprendimento può essere gestito in modo flessibile, consentendo ai responsabili della formazione di progettare contenuti specifici per i propri team, senza dover dipendere da quadri normativi esterni.
In questo senso, iniziative come la formazione eLearning come leva per la trasformazione digitale delle aziende dimostrano come il non formale diventi uno strumento potente per lo sviluppo del talento interno.
Differenze chiave
| Apprendimento formale | Apprendimento informale | |
|---|---|---|
| Struttura | ||
| Struttura | Strutturato, pianificato, con un curriculum definito. | Non strutturato, spontaneo, senza piano di studi. |
| Intenzionalità | ||
| Intenzionalità | Intenzionale, con obiettivi pedagogici definiti. | Non sempre intenzionale; emerge nella pratica o nell’interazione quotidiana. |
| Contesto | ||
| Contesto | Istituzioni educative, programmi ufficiali, aziende con formazione regolamentata. | Luogo di lavoro, social network, conversazioni, pratica quotidiana. |
| Certificazione | ||
| Certificazione | Sì, al termine si ottiene una certificazione riconosciuta. | No, generalmente non prevede una certificazione. |
| Valutazione | ||
| Valutazione | Valutazione sistematica e pianificata. | Non sistematica; basata su osservazione, feedback o risultati. |
| Ruolo del formatore | ||
| Ruolo del formatore | Figura docente chiara, con ruolo di guida e valutatore. | Nessuna figura formale; può avvenire tra pari o come autoapprendimento. |
| Esempi | ||
| Esempi | Scuola, università, corsi certificati, formazione finanziata. | Mentoring informale, osservazione, risoluzione di problemi, ricerche online. |
| Tipo di apprendimento | ||
| Tipi di apprendimento | Teorico-pratico, con basi concettuali solide. | Pratico, basato sull’esperienza diretta. |
| Flessibilità | ||
| Flessibilità | Bassa adattabilità ai ritmi individuali. | Alta adattabilità; avviene in base alle esigenze del momento. |
| Riconoscimento | ||
| Riconoscimento | Riconosciuto a livello istituzionale e lavorativo. | Poco riconosciuto formalmente, ma apprezzato nella pratica. |
| Temporalità | ||
| Temporalità | Durata definita, spesso da medio a lungo termine. | Continuo, senza durata predefinita. |
Contesti di apprendimento formale, non formale e informale: un ecosistema in evoluzione
Anziché considerare questi tipi di apprendimento come compartimenti stagni e isolati, sempre più esperti concordano nel vederli come un sistema interconnesso.
I contesti di apprendimento formale, non formale e informale coesistono nella vita professionale di ogni collaboratore: una persona può frequentare un corso certificato (formale), partecipare a un laboratorio pratico (non formale) e allo stesso tempo apprendere autonomamente affrontando una sfida sul lavoro (informale).
La trasformazione dell’apprendimento richiede di riconoscere questa coesistenza e progettare strategie che valorizzino il meglio di ciascuno. I responsabili della formazione che comprendono come questi contesti si intrecciano sapranno costruire percorsi di apprendimento più efficaci, motivanti e allineati agli obiettivi aziendali.
Dall’apprendimento formale all’interazione costante: il cambiamento di paradigma

Per molto tempo, imparare significava frequentare un corso, ascoltare un esperto e superare un esame.
Questa sequenza lineare si adattava a un mondo del lavoro più prevedibile, in cui le competenze richieste cambiavano lentamente e i titoli accademici erano credenziali sufficienti per un’intera carriera professionale.
Ma questa logica è ancora valida in un contesto in cui ciò che abbiamo appreso cinque anni fa può diventare obsoleto in pochi mesi?
La realtà aziendale attuale richiede una trasformazione dell’apprendimento che non si limita a digitalizzare i contenuti o spostare i corsi online. Va molto oltre: significa passare da un modello di trasmissione unidirezionale a un approccio basato sull’interazione continua tra persone, risorse e contesti.
L’apprendimento formale, con tutta la sua struttura e rigore, è stato attraversato da nuove dinamiche che richiedono flessibilità, dialogo e aggiornamento costante.
La digitalizzazione come acceleratore del cambiamento
Uno dei principali motori di questo nuovo paradigma è stata la trasformazione digitale nell’istruzione e nella formazione aziendale. Non si tratta più solo di accedere a un corso da un computer, ma di integrare strumenti che permettano di interagire, collaborare, personalizzare i ritmi e arricchire l’esperienza formativa con formati multipli.
I LMS di nuova generazione non si limitano a ospitare contenuti, ma, cosa ancora più importante, offrono spazi di comunicazione tra discenti e tutor, forum per il confronto collettivo, funzionalità per il lavoro di gruppo e sistemi di monitoraggio che consentono ai formatori di intervenire attivamente durante il processo.
Invece di limitarsi a valutare i risultati, i responsabili della formazione possono accompagnare, stimolare e potenziare l’apprendimento in tempo reale.
Questo nuovo ecosistema ha reso più labili i confini tra formale e informale: un corso può includere una video-lezione strutturata e, al contempo, favorire l’apprendimento informale tramite sfide, commenti tra pari o progetti collaborativi.
Così, oltre a modernizzare gli strumenti impiegati, la trasformazione digitale della formazione ridefinisce i processi pedagogici.
La cultura dell’apprendimento continuo: oltre l’intervento occasionale
Un altro cambiamento fondamentale è l’evoluzione del concetto di formazione come evento isolato verso una logica di apprendimento costante.
Le aziende non possono più permettersi di dipendere esclusivamente da programmi formativi annuali o da campagne di aggiornamento sporadiche. Ciò di cui hanno bisogno è creare una cultura dell’apprendimento continuo, in cui ogni professionista abbia l’opportunità — e la responsabilità — di aggiornarsi in modo permanente.
Questo cambiamento di mentalità implica passare dal controllo all’accompagnamento, dagli itinerari chiusi ai percorsi personalizzati, e dal contenuto come fine alla conoscenza come mezzo. In questa nuova cultura, i leader promuovono spazi in cui i team possano apprendere in modo autonomo, collaborativo e connesso alle sfide concrete del business.
L’apprendimento formale e informale convivono in questa logica. Da un lato, è ancora necessario disporre di basi strutturate e quadri concettuali solidi. Dall’altro, queste basi vengono arricchite dalla scoperta, dalla curiosità e dallo scambio quotidiano di idee che nasce solo nella pratica, nell’interazione umana e nell’esperienza professionale.
In definitiva, ciò che sta cambiando non è solo la tecnologia, ma il modo stesso in cui intendiamo l’atto di apprendere: meno focalizzato sull’accumulo di conoscenze, e più orientato alla costruzione condivisa del sapere, all’azione e alla trasformazione reale delle competenze in risultati.
Gli spazi in cui l’apprendimento informale prende più forza
Ci sono apprendimenti che non compaiono nei manuali, che non si valutano con esami e non si misurano con certificati.
Imparare significa anche fare una domanda a un collega, affrontare una sfida inaspettata, improvvisare una soluzione e, da lì, migliorare.
Nel contesto aziendale, queste esperienze quotidiane stanno smettendo di essere considerate aneddotiche per occupare un ruolo centrale nella strategia formativa. L’apprendimento informale, lungi dall’essere un complemento, si sta affermando come una delle fonti più efficaci di sviluppo professionale.
Questo cambiamento risponde, in gran parte, alle esigenze attuali del mondo del lavoro: urgenza, adattabilità, collaborazione e capacità di risolvere rapidamente i problemi.
In molti settori, aspettare l’attivazione di un corso formale per acquisire una competenza chiave non è semplicemente praticabile. Ecco perché le organizzazioni che stanno guidando la trasformazione dell’apprendimento sono quelle che creano ambienti in cui imparare in modo informale è facile, naturale e ricorrente.
Imparare proprio quando serve: accesso all’informazione in tempo reale
Immagina che un collaboratore debba comprendere una nuova procedura per risolvere un problema con un cliente. Non ha tempo per iscriversi a un corso né per aspettare che qualcuno lo formi.
Cosa fa? Consulta la banca dati aziendale, chiede a un collega o guarda un tutorial interno.
Questo tipo di reazione, sempre più frequente, è l’esempio perfetto di apprendimento non formale e non strutturato, ma estremamente efficace: l’apprendimento informale basato sull’immediatezza e sull’accesso all’informazione nel momento giusto.
Grazie alla trasformazione digitale nella formazione, oggi è possibile organizzare il sapere interno in modo che sia disponibile quando serve davvero.
Le piattaforme di eLearning permettono di integrare risorse dinamiche, wiki collaborative e materiali accessibili da qualsiasi dispositivo. Così, il contenuto smette di essere un blocco statico e diventa uno strumento vivo al servizio dell’azione.
Il valore dell’apprendimento collaborativo e della mentorship tra colleghi
Un altro spazio in cui l’apprendimento informale si potenzia è la collaborazione tra le persone.
Lontano dalle aule, il sapere circola costantemente nelle conversazioni, nelle dinamiche di gruppo e nei processi di mentorship interna. Non è un caso se molte aziende stanno promuovendo community di pratica, programmi di buddying o iniziative di reverse mentoring: tutte si basano sull’idea che imparare insieme sia più efficace che imparare da soli.
In questi contesti, il ruolo dell’esperto si diluisce e tutti i membri del team possono diventare punti di riferimento in un’area specifica. Questa orizzontalità favorisce il trasferimento del sapere, rafforza i legami tra colleghi e consolida l’idea che lo sviluppo professionale non sia qualcosa imposto dall’esterno, ma costruito dall’interno.
Inoltre, questo approccio ha un vantaggio cruciale: consente di integrare apprendimento non formale e apprendimento informale all’interno della cultura organizzativa. Non è necessario istituzionalizzare ogni processo formativo, ma è fondamentale creare spazi in cui la conoscenza venga condivisa, documentata e riconosciuta.
Feedback costante: il miglioramento come motore dell’apprendimento
Negli ambienti agili e orientati ai risultati, il feedback in tempo reale diventa un motore di apprendimento continuo. Ogni riunione, ogni consegna, ogni feedback costruttivo rappresenta un’opportunità per crescere, correggere e perfezionare le proprie competenze.
Questa dinamica è alla base di molte metodologie di lavoro attuali, dal design thinking alle retrospettive dei team Scrum.
La chiave sta nel creare culture in cui sbagliare sia accettato come parte del processo, a condizione che vi sia una riflessione che permetta di apprendere dall’errore.
In questo contesto, apprendimento formale e informale possono articolarsi in modo complementare: mentre i contenuti formali offrono le basi teoriche, i meccanismi informali aiutano a integrare quella conoscenza nella pratica, adattandola alle sfumature del quotidiano.
Così, la trasformazione digitale nell’istruzione non si limita a digitalizzare i contenuti, ma facilita circuiti di miglioramento immediato. Strumenti di valutazione continua, sondaggi istantanei, chat formative o ambienti collaborativi rendono possibile l’apprendimento nel flusso naturale del lavoro, senza bisogno di fermarsi o aspettare.
Ambiti in cui l’apprendimento formale resta essenziale

Nel pieno entusiasmo per le nuove modalità di apprendimento e per la flessibilità offerta dall’apprendimento informale, è utile fermarsi un attimo. Perché non tutto può — né deve — essere appreso in contesti spontanei o privi di struttura.
Esistono situazioni in cui la sicurezza, l’etica professionale, la precisione tecnica o lo sviluppo umano rendono imprescindibile una base solida, strutturata e validata.
In altre parole: ci sono ambiti in cui l’apprendimento formale non è un’opzione tra molte, ma una necessità insostituibile.
Riconoscere il valore dell’apprendimento formale non significa sminuire altre forme di sviluppo, ma comprendere che ogni contesto formativo ha esigenze specifiche.
Questa è una delle chiavi per gestire con efficacia i contesti di apprendimento formale, non formale e informale: capire quale approccio risponde meglio a ogni esigenza, evitando soluzioni generiche o mode passeggere.
Educazione infantile e bisogni educativi speciali: oltre i contenuti
Nelle prime fasi dello sviluppo, la formazione va ben oltre la trasmissione delle conoscenze. Nell’infanzia si apprende osservando, imitando, interagendo, creando legami e sentendosi al sicuro.
È proprio qui che l’apprendimento formale svolge un ruolo fondamentale: non solo per i contenuti strutturati che vengono trasmessi, ma per la figura dell’educatore come punto di riferimento emotivo, guida e mediatore.
Nel caso della formazione per bisogni educativi speciali, questa componente umana diventa ancora più rilevante. La tecnologia può offrire supporti, accessibilità e risorse preziose, ma non può sostituire la capacità empatica e adattiva di un professionista formato.
La trasformazione digitale nell’istruzione deve essere al servizio di queste esigenze, non sostituirle.
Scuola e università: strutture per sviluppare il pensiero
Durante il percorso scolastico e nei primi anni universitari, l’apprendimento richiede non solo di acquisire informazioni, ma anche di sviluppare strutture di pensiero, competenze critiche e abilità comunicative.
Questo processo necessita di tempo, guida, valutazione formativa e, soprattutto, di un’interazione significativa con altri: docenti, colleghi, tutor.
L’apprendimento informale può integrare — e in effetti lo fa — queste fasi attraverso attività extracurricolari, lavoro collaborativo o risorse digitali. Tuttavia, affidare l’intero processo formativo solo all’iniziativa individuale o a piattaforme automatizzate sarebbe insufficiente e, in molti casi, controproducente.
La trasformazione digitale nell’istruzione superiore, dunque, non dovrebbe puntare a sostituire il docente, ma a rafforzarne la capacità di accompagnare, personalizzare e arricchire l’esperienza formativa del discente.
Carriere professionali ad alta specializzazione tecnica e pratica
Alcune professioni richiedono un livello di precisione e responsabilità tale da rendere indispensabile una formazione rigorosa e supervisionata. Nessuno si sottoporrebbe a un intervento chirurgico con un medico che ha imparato per tentativi, né attraverserebbe un ponte progettato da qualcuno che ha visto solo tutorial video.
In questi casi, l’apprendimento formale è l’unica via che garantisce sia l’acquisizione delle competenze tecniche sia la validazione della loro corretta applicazione.
Ambiti come la medicina, l’architettura o l’ingegneria richiedono percorsi formativi estesi, tirocini supervisionati, simulazioni controllate e valutazioni rigorose. È proprio qui che la combinazione tra tecnologia e pedagogia acquisisce un valore particolare: la trasformazione digitale nell’istruzione può offrire apprendimento immersivo, simulatori, realtà aumentata o sistemi di addestramento virtuale — sempre, però, sotto la supervisione e il supporto di formatori esperti.
Mestieri tecnici e formazione basata sulla pratica: imparare facendo, ma con guida
Ci sono competenze che non si acquisiscono leggendo manuali o osservando da lontano. La meccanica automobilistica, la gastronomia professionale, la falegnameria o i mestieri legati all’edilizia richiedono formazione pratica, osservazione diretta e correzione sul campo. Si impara facendo, ma non in modo casuale.
In questi contesti, apprendimento non formale e apprendimento informale possono avere un ruolo importante — ad esempio tramite mentoring o apprendimento tra pari —, purché si basino su una struttura solida che garantisca qualità, sicurezza e miglioramento progressivo.
Anche qui la sfida è progettare percorsi formativi che combinino il meglio di entrambi i mondi.
In questo senso, piattaforme come evolCampus possono servire da supporto per organizzare contenuti, documentare processi, valutare competenze e dare continuità all’apprendimento anche fuori dall’aula o dal laboratorio. Così, la trasformazione digitale della formazione si adatta anche agli ambienti più manuali e tecnici, senza perdere la sua essenza pratica.
Cosa cerca oggi un professionista? Nuove modalità di apprendimento nell’era digitale

Formarsi non è più solo una questione di scalare gradi accademici o collezionare titoli. Chi oggi è attivo nel mondo del lavoro — soprattutto le nuove generazioni — dà valore ad altre dimensioni dell’apprendimento: autonomia, applicabilità immediata, flessibilità e connessione diretta con le sfide concrete del proprio ruolo.
La trasformazione dell’apprendimento non riguarda solo i metodi o gli strumenti, ma anche le aspettative e le motivazioni di chi apprende.
Ma cosa comporta esattamente questo cambiamento di prospettiva? In che modo la trasformazione digitale nell’istruzione influenza il modo in cui i professionisti si relazionano con la formazione? E, soprattutto, quale ruolo devono assumere le organizzazioni per rispondere a questa nuova domanda?
Autonomia e personalizzazione: apprendere con senso e su misura
Uno dei cambiamenti più significativi è la crescente esigenza di autonomia nel processo formativo. I professionisti non si accontentano più di percorsi predefiniti né di corsi obbligatori che non si collegano alla loro realtà. Cercano esperienze formative che possano adattare ai propri ritmi, interessi e percorso professionale.
Questo ha favorito la diffusione dell’apprendimento informale, in cui ciascuno sceglie le proprie fonti, organizza il tempo e decide cosa e come apprendere.
Dagli articoli ai podcast, dai corsi brevi ai video esplicativi, l’accesso a contenuti specialistici è immediato. E sebbene questo approccio possa sembrare disordinato, risponde a una logica precisa: imparare ciò di cui ho bisogno, quando ne ho bisogno, nel modo più adatto al mio stile.
Le piattaforme LMS avanzate consentono di canalizzare questa autonomia senza perdere struttura. Evolmind, ad esempio, offre funzionalità per personalizzare i percorsi di apprendimento, adattare i contenuti ai profili e accompagnare il processo senza imporre un’unica via.
È proprio qui che si combinano strategicamente elementi di apprendimento formale e informale.
Applicabilità immediata: apprendere per agire, non solo per sapere
Un’altra aspettativa fondamentale è che l’apprendimento abbia un impatto tangibile sulle prestazioni quotidiane.
Non basta più “sapere di più”; ciò che conta è saper applicare quella conoscenza in situazioni reali.
Questo criterio ha portato alla diffusione dell’apprendimento non formale e del microlearning: pillole di contenuto mirate alla risoluzione di problemi concreti, molto contestualizzate e facilmente accessibili.
Questa orientazione alla praticità si rafforza con la trasformazione digitale della formazione, che ha aperto la strada a metodologie come l’apprendimento basato sulle sfide, la gamification o i simulatori interattivi.
Ciò che conta è che l’apprendimento non resti confinato nell’aula virtuale, ma fluisca naturalmente verso l’esperienza professionale.
Inoltre, gli ambienti digitali collaborativi permettono che questa applicabilità venga arricchita dall’interazione tra colleghi. L’apprendimento informale attraverso community interne, forum o mentoring si trasforma in un potente strumento per validare conoscenze, confrontare approcci e migliorare competenze in modo continuo.
Connessione umana ed esperienze significative
Nonostante la crescita della formazione online, i professionisti continuano ad apprezzare — e molto — la dimensione umana dell’apprendimento.
Condividere con gli altri, confrontare idee, sentirsi accompagnati, ricevere feedback, discutere… sono elementi che fanno la differenza tra un’esperienza meccanica e una trasformazione reale.
Qui entrano in gioco i contesti di apprendimento formale, non formale e informale, che coesistono e si rafforzano a vicenda. La chiave sta nel progettare esperienze in cui il digitale non riduca l’umanità, ma la potenzi. Dove la tecnologia non sostituisca il sociale, ma lo amplifichi.
In tal senso, le piattaforme LMS facilitano l’integrazione di forum, aule virtuali, videoconferenze e spazi per la collaborazione attiva, permettendo di mantenere vivo il componente relazionale anche in ambienti 100% digitali.
E la trasformazione digitale nell’istruzione superiore e nel mondo aziendale non significa isolare il professionista dietro uno schermo, ma creare nuove modalità di connessione che si adattino ai suoi ritmi, linguaggi e bisogni.
L’approccio ibrido: la chiave per il futuro dell’apprendimento professionale
E se il vero progresso non fosse scegliere tra ciò che è tradizionale e ciò che è emergente, ma imparare a combinarli con intelligenza?
Di fronte al falso dilemma tra apprendimento formale e apprendimento informale, sempre più organizzazioni puntano su un approccio ibrido, capace di unire la solidità di una base strutturata con l’agilità dell’esperienza pratica. In questa integrazione non c’è contraddizione, ma una risposta più adatta ai bisogni reali dei team e delle aziende.
La trasformazione dell’apprendimento non è una rottura con il passato, ma un’evoluzione. Si tratta di valorizzare ciò che ogni modello offre — rigore, flessibilità, validazione, contesto, personalizzazione — e creare contesti di apprendimento adattivi.
Un approccio che non impone un unico percorso, ma propone una mappa in cui ogni professionista può costruire il proprio cammino.
Imparare con struttura ma con libertà
Il vero valore dell’approccio ibrido è che consente di imparare con sicurezza, senza perdere autonomia. Proprio come un escursionista ha bisogno di una mappa per non perdersi, ma anche della libertà di adattare il ritmo e scegliere deviazioni, un professionista ha bisogno sia di orientamento sia di spazio per esplorare.
L’apprendimento formale e informale si completano in questo schema: uno traccia il percorso, l’altro permette di adattarlo alla realtà.
Ad esempio, un corso strutturato può fornire le basi concettuali di un’area tecnica, mentre una community di pratica permette di scambiare soluzioni e apprendimenti quotidiani sullo stesso argomento. La base teorica dà solidità; l’esperienza informale, applicabilità.
In questo senso, l’apprendimento non formale gioca un ruolo chiave come ponte tra i due: corsi progettati per esigenze specifiche, non vincolati a quadri normativi rigidi ma con obiettivi chiari e metodologia definita.
Esempi di modelli ibridi che funzionano già
Questa combinazione non è solo teorica: è già applicata in molti settori con ottimi risultati.
Nelle aziende, ad esempio, è comune che un onboarding unisca moduli formali (normative, processi, struttura organizzativa) con dinamiche di apprendimento tra pari, sessioni pratiche o risorse on demand che favoriscono l’apprendimento informale, come dimostra lo studio Workplace Learning During Organizational Onboarding: Integrating Formal, Informal, and Self-Regulated Workplace Learning, pubblicato su Frontiers in Organizational Psychology.
Questa ricerca conferma che i processi di onboarding nelle imprese tendono a integrare sia moduli formali — focalizzati su norme, procedure o struttura — sia dinamiche di apprendimento informale, come mentoring tra pari, risoluzione di problemi reali o accesso autonomo a risorse su richiesta. Questo permette ai nuovi dipendenti di acquisire conoscenze chiave mentre si adattano progressivamente all’ambiente e alla cultura aziendale.
Nell’ambito dell’istruzione superiore, molte università stanno sviluppando modelli di blended learning, in cui le lezioni in presenza si combinano con attività autonome, collaborative e digitali.
In questo caso, la trasformazione digitale nell’istruzione superiore non sostituisce l’aula, ma la estende: consente di sfruttare il meglio di entrambi i mondi e rispondere alle nuove esigenze di studenti e mercato.
Un altro esempio frequente si trova nei programmi di reskilling o upskilling nelle aziende tecnologiche, dove si unisce un percorso formale di contenuti tecnici con sfide reali, progetti collaborativi e feedback in tempo reale. In questo modo si valida la conoscenza, si accelera la pratica e si moltiplica l’impatto.
In tutti questi casi, il progetto non parte da una fonte unica, ma da una visione strategica: di cosa ha bisogno questa persona? Quali sono le richieste del contesto? Come possiamo facilitare un apprendimento significativo, misurabile e sostenibile?
La conclusione è chiara: la risposta non sta nel rifiutare il tradizionale né nell’abbracciare il nuovo in modo acritico. La chiave sta nel combinare. Nel progettare esperienze formative in cui ogni strumento abbia un senso, ogni risorsa uno scopo e ogni professionista un ruolo attivo nel proprio sviluppo.
Il ruolo delle piattaforme LMS in questo nuovo paradigma
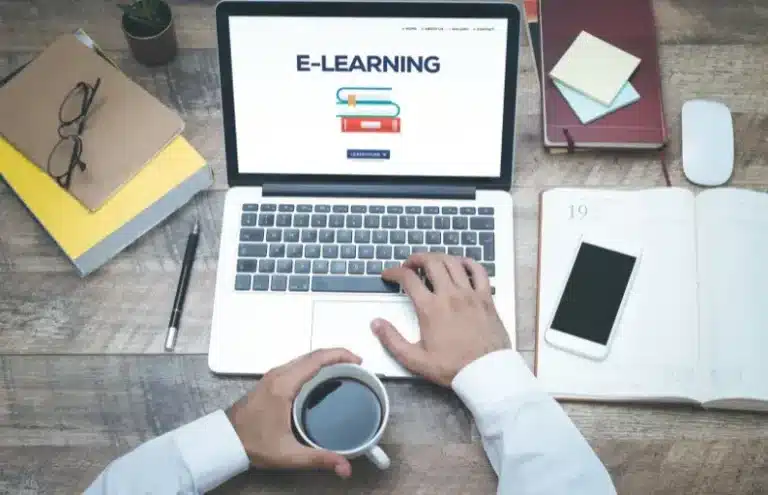
In un contesto professionale caratterizzato dalla rapidità del cambiamento e dalla varietà di formati, le piattaforme LMS si sono evolute da semplici gestori di corsi online a veri e propri ecosistemi di apprendimento.
Il loro valore risiede nella capacità di integrare, in un unico spazio, apprendimento formale, apprendimento non formale e apprendimento informale, creando ambienti coerenti, misurabili e centrati sulle persone.
Da un lato, offrono la struttura necessaria per implementare percorsi formativi solidi: moduli organizzati, piani di formazione certificati, valutazione per competenze e monitoraggio individuale. Questo supporto all’apprendimento formale replica la logica dei contesti educativi tradizionali, con l’accessibilità e la scalabilità del digitale.
Dall’altro lato, il loro vero potenziale emerge quando consentono di integrare esperienze più flessibili, tipiche dell’apprendimento non formale e informale. Forum di discussione, attività pratiche, microlearning o risorse aperte favoriscono la collaborazione, l’autonomia e l’accesso all’informazione nel momento del bisogno. In questo modo, il sapere non viene solo trasmesso, ma costruito in modo dinamico.
Inoltre, queste piattaforme permettono di centralizzare e personalizzare l’intero processo formativo. Agiscono come punto di incontro tra persone, contenuti ed esperienze, rendendo possibile una gestione integrale dell’apprendimento, sia dal punto di vista del reparto formazione che da quello dell’utente finale. Questo include l’adattamento dei percorsi ai diversi profili, la proposta di contenuti rilevanti in base agli obiettivi e la generazione di dati per valutare l’impatto reale della strategia formativa.
Ciò che distingue le soluzioni più avanzate è la capacità di promuovere una cultura dell’apprendimento viva e connessa. Oltre a distribuire contenuti, il valore di queste piattaforme sta nel facilitare lo scambio tra persone, attivare community di apprendimento, stimolare sfide condivise e incentivare il feedback in tempo reale.
È proprio qui che apprendimento formale e informale si intrecciano per offrire esperienze realmente trasferibili nella quotidianità professionale.
Un ambiente strutturato per il formale, flessibile per l’informale
Uno dei principali contributi delle piattaforme LMS è la loro capacità di supportare l’apprendimento formale con il rigore necessario: contenuti organizzati in moduli, piani di formazione certificati, valutazione per competenze, monitoraggio individuale.
In questo senso, replicano la logica dei contesti educativi tradizionali, con il vantaggio di accessibilità, tracciabilità e scalabilità che offre il digitale.
Tuttavia, il vero valore aggiunto si manifesta quando queste piattaforme si aprono anche all’apprendimento non formale e all’apprendimento informale, integrando funzionalità che permettono di combinare percorsi strutturati con spazi di interazione, apprendimento autonomo e collaborazione tra pari.
L’uso di forum, attività pratiche, microlearning o risorse aperte sono solo alcune delle modalità con cui questo si concretizza.
Centralizzazione, personalizzazione e tracciabilità dell’apprendimento
In un contesto in cui la formazione si frammenta in molteplici formati, momenti e dinamiche, disporre di uno strumento che centralizzi tutti i processi diventa fondamentale.
Le piattaforme LMS agiscono come punto d’incontro tra persone, contenuti ed esperienze, permettendo una gestione integrata dell’apprendimento, sia dal punto di vista del reparto formazione che da quello dell’utente.
Questo include la possibilità di personalizzare i percorsi di apprendimento in base ai profili professionali, offrire contenuti adattivi e generare report che, oltre a mostrare il progresso dei corsi, forniscano dati utili per prendere decisioni strategiche.
In questo modo, le organizzazioni possono progettare percorsi formativi strategici e valutare l’impatto reale del proprio investimento nello sviluppo del talento.
Connettere le persone, non solo distribuire contenuti
Oltre alla gestione tecnica, ciò che distingue le piattaforme LMS più evolute è la loro capacità di promuovere una cultura dell’apprendimento viva, collaborativa e basata sullo scambio.
Perché se c’è una lezione che ci ha lasciato la trasformazione dell’apprendimento è che le persone non imparano da sole, né solo dai contenuti, ma soprattutto dall’interazione con gli altri.
Per questo, gli LMS di oggi non si limitano a conservare materiali. Permettono di creare community di apprendimento, incentivare il lavoro di squadra, proporre sfide, facilitare il feedback tra pari e connettere i partecipanti con formatori, tutor o mentor.
L’obiettivo non è più solo completare un corso, ma integrare le conoscenze nella pratica quotidiana, condividerle, arricchirle e applicarle.
In questo nuovo paradigma, le piattaforme LMS si consolidano come elementi chiave per articolare i diversi contesti di apprendimento formale, non formale e informale e per sostenere una visione della formazione che non inizia né finisce in un’aula, ma che scorre, evolve e trasforma il nostro modo di lavorare, relazionarci e crescere come professionisti.
Imparare sempre, imparare in tanti modi
La formazione professionale non può più essere vista come una scelta tra metodi. La chiave sta nell’integrare apprendimento formale, apprendimento non formale e apprendimento informale in un sistema flessibile, umano e allineato con le sfide del presente.
Il contesto attuale richiede professionisti in grado di pensare con rigore, agire con agilità e apprendere in modo continuo. Tutto questo è possibile solo se si combina la struttura che dà sicurezza con l’esperienza pratica che permette di adattarsi e crescere.
Le organizzazioni che hanno compreso questo stanno smettendo di offrire corsi isolati per costruire vere e proprie culture dell’apprendimento.
In questo percorso, le piattaforme LMS agiscono come alleate strategiche. Consentono di creare ponti tra modalità di apprendimento diverse, attivare processi e sostenere lo sviluppo professionale nel tempo.
La sfida non è tecnica, ma di visione: progettare esperienze formative che rispondano ai bisogni reali delle persone, oggi e domani. In questo processo, trovare l’equilibrio tra apprendimento formale e informale non è un obiettivo fine a sé stesso, ma una leva chiave per trasformare il modo in cui lavoriamo, condividiamo conoscenza e generiamo valore nelle organizzazioni.
FAQs